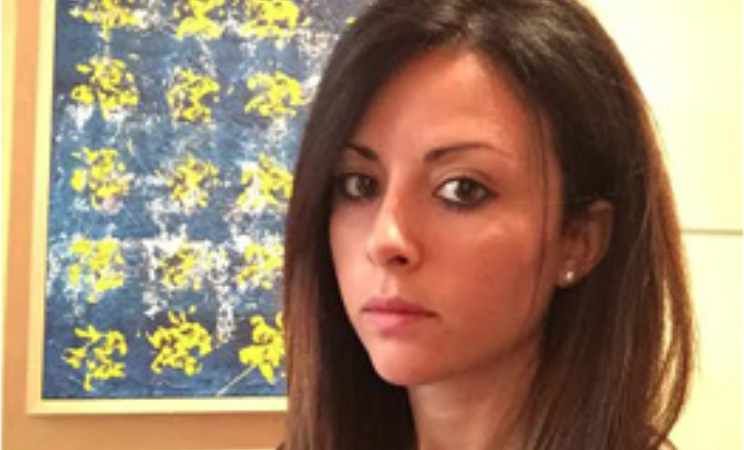
La pronuncia delle Sezioni Unite in relazione ai contratti monofirma
Avv. Claudia Promutico
I contratti di borsa sono le fattispecie contrattuali attraverso cui si realizzano, fra intermediari autorizzati, la negoziazione e lo scambio nei mercati regolamentati di strumenti finanziari ufficialmente quotati.
L’attività negoziale diretta allo scambio di strumenti finanziari rappresenta in realtà l’ultima fase di un iter giuridico articolato e complesso che corrisponde all’operatività di borsa.
Si tratta di una contrattazione a doppio stadio che presuppone il contratto quadro e il contratto esecutivo.
Il contratto quadro è quello stipulato tra l’investitore e una società di intermediazione finanziaria che non possiede le azioni ma si impegna, per conto del cliente, ad acquistarle.
La prevalente dottrina e giurisprudenza inquadra tale tipologia contrattuale nel contratto normativo. Infatti, con il contratto quadro la banca e l’investitore stabiliscono le condizioni di acquisto che dovranno essere rispettate nei singoli contratti attuativi.
Il contratto quadro è definito come “quell’accordo normativo o programmatico la cui causa consiste nel regolare in via preventiva una indefinita serie di negozi – a cui tuttavia potrebbe anche non seguire operazione d’investimento – e con cui l’intermediario pone la sua organizzazione di impresa a disposizione del cliente”.
L’art. 23 del Tuf prevede che tali contratti sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE e un esemplare è consegnato ai clienti, salvo facoltà di deroga consentita alla Consob, per la previsione con regolamento di altra forma applicabile a particolari tipi di contratto, qualora motivate ragioni o la natura professionale dei contraenti lo richieda.
Pertanto, mentre il cliente ha a disposizione la copia del contratto con entrambe le sottoscrizioni, l’intermediario possiede unicamente la copia sottoscritta dal solo cliente.
Da tali premesse si è posta la questione, oggi risolta dalle Sezioni Unite con sentenza del 16 gennaio 2018, n.898, della sorte dei contratti monofirma.
Secondo un primo orientamento il contratto doveva ritenersi nullo ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 1325 n.4, in quanto la sottoscrizione è elemento essenziale del contratto. Tuttavia, sostenendo la nullità del contratto quadro si pone un ulteriore problema relativo alle sorte dei singoli contratti esecutivi. Invero, aderendo alla tesi della nullità del contratto quadro il cliente, parte debole del rapporto contrattuale, nel caso in cui il mercato abbia un andamento diverso rispetto a quello sperato potrebbe far valere in giudizio la nullità del contratto quadro monofirma ottenendo anche la nullità del contratto esecutivo per lui svantaggioso.
La giurisprudenza però ha sostenuto che la produzione in giudizio del contratto da parte della banca in assenza di firma del funzionario della stessa vale come sottoscrizione. La produzione in giudizio del contratto si configurava quindi come sottoscrizione differita dello stesso con valenza ex nunc e non retroattiva.
Ebbene, la sanatoria quindi non aveva effetto ex tunc ma ex nunc con la conseguenza che in ogni caso il contratto esecutivo restava nullo a vantaggio del risparmiatore in mala fede.
L’unica possibilità per la banca era quella di far valere l’abuso del diritto, opponendo l’exceptio doli generalis in quanto il cliente essendo in mala fede ha posto in essere un comportamento abusivo.
Secondo un diverso orientamento, fatto proprio dalle Sezioni Unite, il contratto quadro non è nullo in quanto è sufficiente la firma del solo cliente.
Secondo la Cassazione, infatti, la sottoscrizione serve per proteggere la parte debole, ne consegue che è sufficiente che sia presente unicamente la sottoscrizione del cliente che è la parte debole del rapporto, mentre la sottoscrizione della banca può essere desunta anche da fatti concludenti non essendo necessaria la sottoscrizione vera e propria.
La lettura fornita dalle Sezioni Unite lungi dal sostenere che esistono due nozioni di forma scritta ad substantiam del contratto fornisce una notazione sul significato del fenomeno del c.d. “neoformalismo negoziale” con cui si indica l’utilizzo da parte del legislatore di prescrizioni di forma volte a realizzare sia finalità di protezione di uno dei contraenti sia finalità di tutela del buon andamento delle contrattazioni.
Il pregio della decisione delle Sezioni Unite è, da un lato, di aver composto un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di legittimità sulla necessità o meno della sottoscrizione del funzionario di banca, che aveva portato i giudici di merito ad adottare decisioni difformi, ma anche di aver posto in giusta evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l’obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. È evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest’ultimo copia dello stesso.
